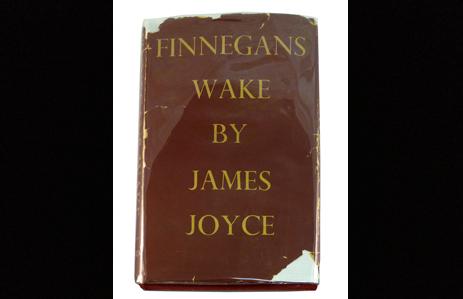Finnegans Wake, o del subconscio

Dopo il rivoluzionario Ulysses, con Finnegans Wake James Joyce scardina le fondamenta del linguaggio e le fa esplodere, utilizza svariati gerghi e idiomi, e da questi costruisce una lingua tutta sua con la quale citare, parafrasare, ricostruire ed esplorare gli intrichi della storia, delle rivoluzioni scientifiche, delle espressioni artistiche e letterarie del passato. Lo scopo era quello, duplice, di dare voce all'ineffabile dimensione onirica del subconscio e di ricreare, attraverso il linguaggio e le sue ramificazioni etimologiche, l'intera storia dell'umanità nel suo processo evolutivo. Un meandertale, come nel termine di Joyce stesso: un racconto-labirinto che, per assonanza, richiama il termine “neanderthal” e dunque rimanda alle origini dell'uomo e della civiltà, proponendo una visione antropologica e antropocentrica della vita e della storia (e non teologica o teocentrica). Ma “meander” significa anche “girovagare”, “vagabondare” e, riferito a un fiume, “serpeggiare”. Ed è proprio il fiume serpeggiante che fornisce a Joyce l'immagine iniziale per descrivere il carattere liquido, acquoso e scorrevole dell'opera: “riverrun, past Eve and Adam's, from swerve of shore...”. Un fiume estremo, un “fluidofiume” (traduzione di Luigi Schenoni) che serpeggia nei meandri più tortuosi e reconditi della storia, del linguaggio e della mente umana. Joyce descrisse il metodo come lo “scavo simultaneo di una serie di gallerie in una montagna, partendo da punti diversi”. E per fare questo i limiti del linguaggio dovevano essere attaccati. “Una gran parte della vita umana”, scrive Joyce, “si passa in uno stato che non può essere ricreato con la lingua di quando si è svegli, né con una grammatica corretta o attraverso una trama che procede diritta alla meta”. E ci tiene a sottolineare la differenza con Ulysses, per lui già superato: “Certi miei critici come Pound o Weaver dicono che è oscuro. Ovviamente lo paragonano a Ulysses. Ma l'azione di Ulysses era principalmente diurna, mentre qui avviene di notte... e le cose non possono essere chiare di notte, o no?”.
Ispirato anche alle Età di Giambattista Vico (ma dentro troviamo davvero tutto, da Bruno, a Shakespeare, da Dante a Newton), il libro è formato da tre sezioni lunghe (i tre corsi: Dei, Eroi e Uomini) seguite da un quarto libro più breve, il ricorso vichiano. Lo stesso titolo riproduce la struttura: tre capitoli lunghi e uno breve che equivalgono alle tre sillabe di Finnegans e all'unica sillaba di Wake. Un libro infinitamente circolare e ironicamente “too-dimensional” (non a due dimensioni – two-dimensional – e neanche tre, ma a “troppe dimensioni”) in cui l'ultima frase non ha un punto ma prosegue nella prima, alla prima pagina: “A way a lone a last a loved a long the / riverrun...”. E in questa vertiginosa multi-dimensionalità e multi-direzionalità, le infinite combinazioni atomistiche delle minime particelle linguistiche creano una narrazione continua, e insieme simultanea, giungendo alla possibilità che diverse realtà spazio-temporali convergano non solo in un singolo brano o in un singolo episodio ma finanche all'interno di una singola parola, di un “pun” o di una cosiddetta “parola valigia”. Così come, ad esempio, nel titolo: Finnegans Wake è sia La veglia di Finnegan, sia il plurale simbolico di tutti i Finnegans che si svegliano (laddove Finnegans è il soggetto del verbo wake). Ma è anche, e soprattutto, una veglia fin-negans (se Finnegans è aggettivo), ossia una veglia che nega (“negans” in latino) la fine (“fin”, in francese). Un ciclo senza fine dunque, come quello della natura e della storia umane. E come quello intrapreso e vissuto da chi legge: un libro-ciclico che si interrompe e si riavvia allo stesso tempo, continuamente, innestando imprevedibili meccanismi mentali ed emotivi capaci di altrettanto imprevedibili rivelazioni.